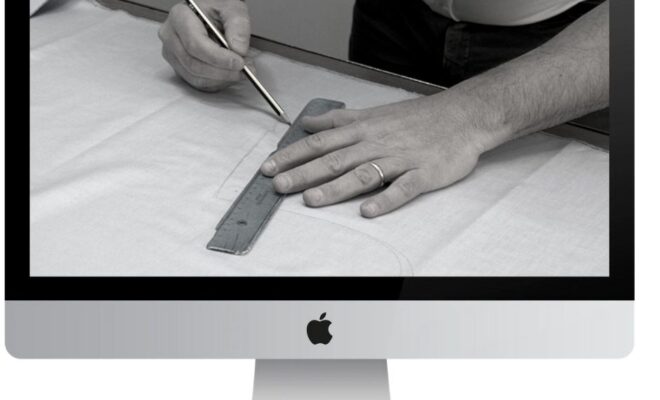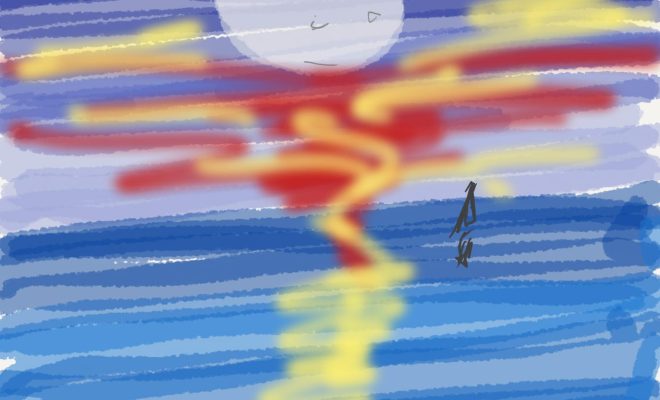Cina e costo del lavoro

La Cina è la fabbrica del mondo, ma non la stessa di venti anni fa. Nell’immaginario comune la Cina è quel paese dove conviene delocalizzare perché il costo del lavoro è minimo e i diritti degli impiegati praticamente inesistente. Per farla in breve, spesso si è portati a credere che l’economia cinese si regga su legioni di bambini chiusi in qualche sottoscala a cucire palloni da esportare nei ricchi paesi occidentali.
Tale convinzione ha smesso di essere vera, a patto che lo sia mai stata, da qualche decennio. La Cina vanta un’industria estremamente sofisticata, che spinge sul pedale dell’acceleratore specie in campo militare e tecnologico. E se alcuni dei topoi sull’Impero di Mezzo (come gli scarsissimi diritti sindacali) restano veri, il mondo del lavoro cinese sta andando incontro a importanti mutamenti.
A partire dal suo ingresso nel WTO nel 2001, la Repubblica Popolare Cinese ha visto la sua economia crescere tra il 7% e il 15% annuo e sarà, quasi unica al mondo, ad accrescere timidamente il PIL anche nel 2020. A partire dal 1978, anno della prima apertura all’economia di mercato, circa 850 milioni di cinesi sono usciti dalla povertà assoluta. Oggi sono circa 5,5 i milioni di cinesi sotto la soglia di povertà, nel 2012 erano circa 100 milioni. Una crescita economica miracolosa, che ha portato ad una progressiva crescita delle città a danno delle campagne, con la creazione di alcune delle megalopoli più grandi del pianeta, come Shenzen o la stessa Shangai.
Il processo di urbanizzazione cinese non si è mai fermato a partire dai primi anni ’60, quando il regime alimentare privilegiato dei centri urbani rispetto alle campagne determinò l’inizio dell’esodo rurale. Un’altra serie di incentivi arrivò con le aperture di Deng Xiaoping che fecero delle città, specie quelle portuali, il motore dell’economia cinese.
Nel 1982, solo il 21% dei cinesi abitava in centri urbani (215 milioni), nel 2015 la percentuale era del 56% (circa 771 milioni). Molti di questi erano Cinesi immigrati in maniera irregolare, nonostante la crescente necessità di manodopera spinse il governo di Pechino a chiudere un occhio (alle volte addirittura incoraggiandole) sulle violazioni. Nel 2014 il Consiglio di Stato prevedeva che la popolazione urbana sarebbe arrivata al 60% nel 2020.
Per evitare eccessive concentrazioni nei grandi centri urbani il governo di Pechino ha adottato una serie di misure ambivalenti. Da una parte ha regolarizzato buona parte di chi era immigrato nelle città negli ultimi anni, mentre dall’altra ha facilitando il passaggio dai distretti rurali a quelli urbani più piccoli, rendendo molto stringenti i requisiti per stabilirsi nelle grandi città. Ma il Partito ha anche avviato un imponente campagna di accorpamento e urbanizzazione degli stessi centri rurali. Ai funzionari pubblici è stato dato mandato per accorpare i piccoli centri agricoli in cittadine rurali, determinando spesso e volentieri la deportazione degli abitanti nei nuovi centri, spesso distanti dai terreni agricoli da cui dipendono.
La gran parte di questi terreni è classificato come “proprietà collettiva”, statuto che vanifica qualsiasi pretesa degli stessi contadini ad opporsi ai piani di ingegneria geografica del partito. Spesso le ridislocazioni avvengono tramite l’uso della coercizione e non è raro assistere a incidenti o morti sospette, come quello del 2015 in cui un contadino perse la vita a seguito del lancio di bombe molotov contro la sua abitazione (per i funzionari, il fuoco era stato appiccato da lui).
Una storia interessante è quella raccontata da Claudio Visetti nel 2014, corrispondente di Repubblica. Il villaggio di Luotuowan nella provincia di Hebei (nord della Cina) era uno dei villaggi più poveri dell’Impero di Mezzo appena dieci anni fa. Oggi rispetto al 2012 il salario è triplicato e la cittadina accoglie avvenieristiche strutture come all’occidentale e infrastrutture produttive. Ma il passaggio non è stato indolore. Nel 2014 il villaggio fu scelto come esperimento per la rinascita delle aree rurali per diventare fiore all’occhiello del miracolo cinese.
L’obiettivo è stato realizzato al prezzo dello sradicamento della sussistenza agricola dell’insediamento, le modeste case dei contadini abbattute e sostituite da moderni condomini, i campi adesso ospitano fabbriche. Di fatto, come racconta Visetti, il contadino cinese è un tipo umano condannato all’estinzione, al partito non serve, non consuma e non produce oltre la propria sussistenza. È un “ramo secco”, destinato all’emancipazione nella nuova Cina, ormai proiettata esclusivamente nella competizione con l’egemone americano, che non ammette alcuno spreco di energie.
Le nuove possibilità offerte dalle città, insieme alla crescita esponenziale dell’economia e allo stabilirsi di società occidentali nei centri produttivi non è stata priva di ricadute. Sull’onda dello sviluppo economico costante, il costo del lavoro è cresciuto continuamente dal 2003. 17 anni fa il salario medio di un lavoratore in area urbana era 13.900 yuan al mese. Nel 2015 aveva toccato i 50.700 yuan.
Le nuove misure in termini di salario minimo, specie quelle del 2017-2020, sebbene molto differenziate, hanno portato i lavoratori delle aree più densamente popolate/industrializzate (Pechino, Shangai, Guangdong) ad un salario minimo di circa 27.000 yuan annuali. Lo stipendio medio di un lavoratore di Shangai nel 2019 ammontava a 115.000 yuan (più dello stipendio medio in alcuni paesi europei come la Croazia). Ad incidere sull’aumento dei salari, insieme alla concentrazione urbana e allo sviluppo, gli investimenti stranierei e la parziale diminuzione del bacino di manodopera cittadina.
Proprio l’aumento del costo del lavoro è un indicatore importante per comprendere il futuro dell’economia cinese. Parte del miracolo sinico riposa infatti sulle delocalizzazioni di grandi aziende occidentali. Mano a mano che i prezzi aumentano viene meno anche la convenienza delle società a delocalizzare le produzioni in Cina, spingendole a spostare parte della filiera in altri paesi del Sud Est Asiatico o dell’America Latina dove il costo del lavoro è ancora molto basso.
Questo fenomeno si salda all’aumento della tensione politica tra l’Occidente a guida americana e la Cina, con l’emissione di reciproche sanzioni che rendono sempre più calda la posizione delle aziende offshore. Nonostante la maggior parte delle aziende occidentali abbia ancora forti interessi a rimanere, sempre più spesso queste rilevano la volontà del personale europeo o americano di trasferirsi in altre sedi.
Secondo la Camera di Commercio americana nel corso del 2019 “più del 70% delle società americane che operano nella Cina meridionale stanno considerando di diminuire ulteriori investimenti nella regione e spostare una parte o la totalità della produzione in altri paesi di fronte all’effetto della guerra commerciale sui profitti”.
Tra queste figurano colossi della tecnologia (americani e di paesi alleati) come Apple, Samsung, HP, Dell, Microsoft e Foxconn. Un altro sondaggio tuttavia, condotto sulle aziende americane che operano a Shangai, ha rivelato come appena il 10% di queste stiano realmente valutando di levare le tende.
Tuttavia, se la Cina vuole essere realmente competitiva con gli Americani, ha necessità di strutturare un’economia più solida, che dipenda il meno possibile da un estero sempre più ostile. Il grande mare globalizzato (americano) è sempre meno sicuro per i cargo che esportano l’oro cinese (le merci acquistate in Occidente) e così il Partito è corso ai ripari. Il 26 ottobre di quest’anno, insieme al nuovo piano quinquennale, è stato varato il programma Vision 2035 che introduce il concetto di doppia circolazione. La locuzione allude al doppio ciclo dell’economia cinese del futuro. Da una parte la Cina ha bisogno di mantenere la sua imponente capacità industriale, da rivolgere interamente verso l’estero, anche in funzione di softpower.
Contemporaneamente, va sviluppata la circolazione interna. I pilastri del sistema interno devono essere l’autarchia tecnologica (si pensi alle difficoltà di Huawei a reperire i semiconduttori in seguito ai dazi americani) e, soprattutto, lo sviluppo del mercato interno. Bisogna fare del miliardo e mezzo di abitanti del celeste impero una legione di consumatori. Sia per fornire nuova linfa alle aziende cinesi che per avviarsi allo standard dei grandi imperi della storia, da sempre prima compratori e poi venditori.
Un sogno cinese 2.0 che, hanno deciso a Pechino, non può più permettersi una popolazione di modesti contadini.